Giovanni Verga
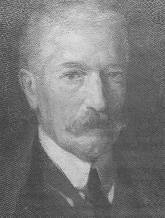 Nei
romanzi giovanili, la figura femminile che attrae la fantasia di Verga si ispira
al modello romantico. Situazioni tipiche della produzione mondana sono: una
passione amorosa travolgente, “romantica”, o contrastata o vissuta
conflittualmente dai protagonisti, o comunque con conclusioni quasi sempre
drammatiche; una tipologia femminile in cui si intrecciano bellezza, bizzarria,
lussuria e una società gaudente.
Nei
romanzi giovanili, la figura femminile che attrae la fantasia di Verga si ispira
al modello romantico. Situazioni tipiche della produzione mondana sono: una
passione amorosa travolgente, “romantica”, o contrastata o vissuta
conflittualmente dai protagonisti, o comunque con conclusioni quasi sempre
drammatiche; una tipologia femminile in cui si intrecciano bellezza, bizzarria,
lussuria e una società gaudente.
Perciò
mentre negli anni Sessanta si apre un vivace dibattito sull’emancipazione
della donna e sul suo diritto alla partecipazione alla vita politica,
l’immagine femminile dominante nella narrativa tardo-romantica e nei romanzi
verghiani, da Una peccatrice (1866) in cui, la protagonista,
Narcisa, sacrifica tutto all’amore anche urtando contro le convenzioni sociali
e il perbenismo borghese, a Eva (1873) figura della ballerina in
cui si incarna la seduzione femminile prima sublimata nella dea, è quello della
donna fatale, della dominatrice che emana un fascino distruttivo. La seduzione
femminile è associata ad un particolare stato sociale (aristocratico) o a un
particolare ruolo (ballerina). Si tratta in ogni caso di una donna di lusso.
L’attributo fondamentale della sua bellezza è l’artificio, relativo alla
persona (trucco, abbigliamento) e all’ambiente in cui ella si muove (festa,
ballo, teatro). E’ avvertibile in questi romanzi l’opposizione tra natura e
artificio, il rifiuto della naturalezza, considerata materialità opaca e
volgare. Il corpo femminile non è più sublimato come simbolo della divina
armonia della natura. Il suo fascino ora dipende solo dall’artificio, dal
mascheramento estetico.
…
e in mezzo ad un nembo di fiori, di luce elettrica, e di applausi apparve una
donna splendida di bellezza e di nudità, corruscante febbrili desideri dal
sorriso impudico, dagli occhi arditi, dai veli che gettavano ombre irritanti
sulle forme seminude, dai procaci pudori, dagli omeri sparsi dei biondi capelli
… [Eva,
Tutti i romanzi, Firenze 1983]
Cotesta
donna avea tutte le avidità, tutti i capricci, tutte le sazietà, tutte le
impazienze nervose di una natura selvaggia e di una civiltà raffinata – era
boema, cosacca e parigina – e nella felina pupilla corruscavano delle bramosie
indefinite ed ardenti. [Tigre
reale, Tutti in romanzi, Firenze 1983]
Il profumo, i veli, i velluti, i gioielli, la danza trasformano la donna in fata, maga, «fiore delicato», «farfalla». Il topos medievale dell’apparizione miracolosa della donna si trasforma, nella civiltà delle banche e delle imprese industriali, nel mito della forma che compare sul palcoscenico e trionfa su un pubblico pagante e plaudente, da cui in realtà dipende. Se cadono gli orpelli, la realtà della donna si rivela in tutta la sua miseria, essa diventa «bruco», «verme» e suscita repulsione.
Pur appartenendo alla produzione mondana, la protagonista di Storia di una capinera (1871) non rientra nel gruppo delle donne fatali. Il romanzo, ambientato in Sicilia, narra la vicenda dell’amore travolgente e fatale che la protagonista prova per un giovane, amore impedito dalla monacazione forzata di lei e dal matrimonio di lui, e che porterà Maria al deperimento e alla morte per consunzione in convento.
L’incontro con la Scapigliatura, a Milano, suscitò nello scrittore un moto di ripulsa verso la società borghese; è in questo periodo che comincia a delinearsi nella sua mente il progetto di un ciclo sui “vinti”, ossia di un’epopea sui deboli travolti dalla marea del progresso. E’ del 1874 il bozzetto siciliano Nedda, con cui nasceva l’immagine della contadina siciliana caratterizzata da quel chiuso e silenzioso volto, da quella desolata rassegnazione, da quella schiva semplicità di espressione e di gesti. Nedda vive in un mondo che ha già le sue leggi e la sua fisionomia che la disprezzerà quando, dopo la morte del fidanzato diventerà madre.
La svolta definitiva verso il verismo si ha con la raccolta di novelle Vita dei campi e soprattutto con i romanzi del ciclo dei Vinti. Verga riesce ora rappresentare la realtà dal punto di vista dei personaggi, gli “umili” siciliani, regredendo in essi, parlando la loro lingua, assumendo la loro cultura, il loro modo di vedere le cose, lasciando cioè che questi si presentino da sé.
Dal punto di vista dell’immagine femminile, mentre con Eva Verga segna il momento di crisi nella rappresentazione ottocentesca della donna, è nella società primitiva di Vita dei campi che Verga riscopre l’energia e l’autenticità dei sentimenti, scomparsi nella società borghese. Motivi romantici e caratteri naturalistici si fondono nella nuova figura contadina di donna fatale, rappresentata dalla Lupa. Isolata dalla comunità, la Lupa si integra perfettamente nella natura selvaggia e bruciata dei luoghi, manifestazione estrema di una sensualità panica e demoniaca; non dea che incanta e seduce, ma essere maledetto il cui potere terribile ha i caratteri del maleficio da esorcizzare («Le donne si facevano la croce quando la vedevano passare»). La passione della Lupa è ossessione, e la sua sensualità aggressiva è associata alla distruzione. L’attributo animale fa della Lupa un archetipo dell’eros insaziabile e insieme rivela un’ottica nuova, la paura con cui l’uomo del secondo Ottocento guarda alla donna avvertita come minaccia alla propria integrità psichica e familiare (Nanni, vittima della Lupa, incarna questo dramma della passione come perdita di se è, del proprio ordine morale, familiare e sociale, a cui egli si ribella con tutte le forze fino al delitto).
Una figura di donna simile a quella di Storia di una Capinera e Nedda è presente nel romanzo I Malavoglia; si tratta di Mena, protagonista di un sentimento amoroso represso e negato che può esprimere solo attraverso silenzi, fughe, allusioni, gesti e parole carichi di malcelato desiderio. Il capitolo VI de I Malavoglia, inoltre, è quasi tutto dedicato alla “rivolta delle donne” contro il dazio della pece. Per un verso, Verga accusa la classe burocratico-amministrativa di corruzione, per un altro tende a screditare la rivolta, attribuendola alle “femmine” mosse da odi e rancori personali. Al pessimismo politico-sociale fa riscontro l’ottimismo nei confronti della famiglia: solo nel suo ambito c’è solidarietà, collaborazione, affetto. Non però uguaglianza; la famiglia è una società organica, in cui alla parità di diritto in generale, corrisponde la differenza delle funzioni: tra i sessi, tra adulti e bambini, e via dicendo.
Dopo Vita dei campi e I Malavoglia, nelle novelle rusticane diventa dominante il tema della roba e la logica economica, che ossessiona il mondo dei poveri, distruggendo affetti e passioni. L’amore non avrà più alcun diritto e la donna dovrà sottomettersi a questa logica.