|
La Letteratura Italiana nella scuola
di
Antonio Stanca
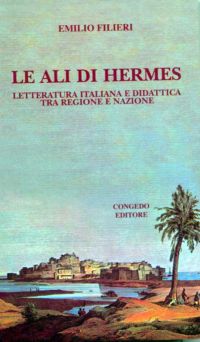 Presso
l’editore Congedo di Galatina (Lecce), nella collana “Minima” diretta da
Lucio Galante dell’Università del Salento (Dipartimento dei beni delle
arti e della storia), è recentemente comparso il volume di Emilio
Filieri, docente di Letteratura italiana all’Università di Bari e
Presidente dell’A.D.I. (Sezione didattica), “Le ali di Hermes
(Letteratura italiana e didattica tra regione e nazione)”. L’opera, che
contiene saggi già pubblicati ed altri inediti, intende continuare e
ampliare la precedente del Filieri “Letteratura e scienza tra Salento e
Napoli”, Galatina, Congedo, 2002. Ne “Le ali di Hermes” l’autore,
impegnato pure presso la SSIS di Lecce, vuole mostrare quanto sia
importante l’insegnamento e l’apprendimento della Letteratura italiana
nella nostra scuola media superiore e come esso dovrebbe avvenire.
Ritorna più volte sul concetto di Letteratura, lo libera da ciò che gli
sembra possa appesantirlo o ridurlo e indica tutte le potenzialità,
tutti i vantaggi che ai giovani deriverebbero dallo studio letterario,
tutte le possibilità di ampliamento, consolidamento delle loro
conoscenze, affinamento dei loro gusti, definizione del loro carattere,
formazione della loro personalità, della loro coscienza civile e
sociale. Fa degli studenti della media superiore i protagonisti della
nuova scuola, li sottrae ad ogni condizione di passività, di
subordinazione e li mette in una di evoluzione, di crescita qualunque
sia il loro stato di partenza. Il diretto contatto con i testi, antichi
e moderni, della storia letteraria, italiana e straniera, rappresenta
uno dei momenti più importanti di tale processo poiché fa agire gli
studenti, li fa vivere insieme ai libri in una “comunità ermeneutica”,
nella quale si annullano i confini tra passato e presente e il docente
diviene un novello Hermes, un messaggero instancabile, una guida sempre
pronta a ripartire, ricominciare, annunciare, informare, consigliare,
dirigere. Nella scuola del Filieri l’insegnante d’Italiano è il più
idoneo a svolgere un’operazione così estesa dal momento che con tante
altre discipline la sua interagisce e più d’ogni altra riesce a
soddisfare le molteplici richieste dei giovani della moderna società,
dei loro ambienti, delle loro forme di comunicazione. La classe deve
trasformarsi in un laboratorio sempre attivo, sempre aperto, sempre
pronto a muoversi, ad accogliere le più diverse influenze, conoscenze,
esperienze e valutarle, regolarle senza, tuttavia, pensare mai di farlo
in maniera totale o definitiva. In tale movimento va fatta rientrare
anche la cultura del territorio, va immessa nel più ampio contesto
nazionale, studiata nelle sue relazioni con esso, vista come una delle
sue parti dalla quale non si può prescindere. Per questo il Filieri
presenta, nel libro, alcuni esempi di moduli (tematico, incontro con
l’opera, genere letterario, ritratto d’autore), li correda di una
documentazione minuziosa sia per i testi sia per la loro critica e li
dedica ad autori salentini che nel passato, più vicino o più lontano,
sono assurti ad una posizione di rilievo, hanno rappresentato un punto
di riferimento, di contatto con quanto avveniva nella storia, nella
cultura, nell’arte, nel costume della nazione, con gli avvenimenti e
personaggi generalmente noti e ritenuti distintivi di essa. Dalla
regione si giunge così alla nazione, dalla periferia al centro
contribuendo anche ad allargare questo, a fargli comprendere altro, a
procurargli una condizione più ampia e più mossa. Presso
l’editore Congedo di Galatina (Lecce), nella collana “Minima” diretta da
Lucio Galante dell’Università del Salento (Dipartimento dei beni delle
arti e della storia), è recentemente comparso il volume di Emilio
Filieri, docente di Letteratura italiana all’Università di Bari e
Presidente dell’A.D.I. (Sezione didattica), “Le ali di Hermes
(Letteratura italiana e didattica tra regione e nazione)”. L’opera, che
contiene saggi già pubblicati ed altri inediti, intende continuare e
ampliare la precedente del Filieri “Letteratura e scienza tra Salento e
Napoli”, Galatina, Congedo, 2002. Ne “Le ali di Hermes” l’autore,
impegnato pure presso la SSIS di Lecce, vuole mostrare quanto sia
importante l’insegnamento e l’apprendimento della Letteratura italiana
nella nostra scuola media superiore e come esso dovrebbe avvenire.
Ritorna più volte sul concetto di Letteratura, lo libera da ciò che gli
sembra possa appesantirlo o ridurlo e indica tutte le potenzialità,
tutti i vantaggi che ai giovani deriverebbero dallo studio letterario,
tutte le possibilità di ampliamento, consolidamento delle loro
conoscenze, affinamento dei loro gusti, definizione del loro carattere,
formazione della loro personalità, della loro coscienza civile e
sociale. Fa degli studenti della media superiore i protagonisti della
nuova scuola, li sottrae ad ogni condizione di passività, di
subordinazione e li mette in una di evoluzione, di crescita qualunque
sia il loro stato di partenza. Il diretto contatto con i testi, antichi
e moderni, della storia letteraria, italiana e straniera, rappresenta
uno dei momenti più importanti di tale processo poiché fa agire gli
studenti, li fa vivere insieme ai libri in una “comunità ermeneutica”,
nella quale si annullano i confini tra passato e presente e il docente
diviene un novello Hermes, un messaggero instancabile, una guida sempre
pronta a ripartire, ricominciare, annunciare, informare, consigliare,
dirigere. Nella scuola del Filieri l’insegnante d’Italiano è il più
idoneo a svolgere un’operazione così estesa dal momento che con tante
altre discipline la sua interagisce e più d’ogni altra riesce a
soddisfare le molteplici richieste dei giovani della moderna società,
dei loro ambienti, delle loro forme di comunicazione. La classe deve
trasformarsi in un laboratorio sempre attivo, sempre aperto, sempre
pronto a muoversi, ad accogliere le più diverse influenze, conoscenze,
esperienze e valutarle, regolarle senza, tuttavia, pensare mai di farlo
in maniera totale o definitiva. In tale movimento va fatta rientrare
anche la cultura del territorio, va immessa nel più ampio contesto
nazionale, studiata nelle sue relazioni con esso, vista come una delle
sue parti dalla quale non si può prescindere. Per questo il Filieri
presenta, nel libro, alcuni esempi di moduli (tematico, incontro con
l’opera, genere letterario, ritratto d’autore), li correda di una
documentazione minuziosa sia per i testi sia per la loro critica e li
dedica ad autori salentini che nel passato, più vicino o più lontano,
sono assurti ad una posizione di rilievo, hanno rappresentato un punto
di riferimento, di contatto con quanto avveniva nella storia, nella
cultura, nell’arte, nel costume della nazione, con gli avvenimenti e
personaggi generalmente noti e ritenuti distintivi di essa. Dalla
regione si giunge così alla nazione, dalla periferia al centro
contribuendo anche ad allargare questo, a fargli comprendere altro, a
procurargli una condizione più ampia e più mossa.
Il procedimento
modulare è quello seguito dal Filieri in tale lavoro di recupero e
rivalutazione della cultura del territorio salentino ed è quello da lui
consigliato ai docenti per lo studio della Letteratura italiana nella
scuola superiore giacché comporta, tra l’altro, il rapporto diretto con
i testi molto proficuo per l’istruzione e formazione degli alunni. A
conclusione del suo volume e seguendo tale direzione il Filieri indica
alcune delle più riuscite storie-antologie di questi ultimi anni e ne
auspica l’inserimento in ogni scuola. Sono opere di noti studiosi che
hanno fatto dell’insegnamento modulare il loro obiettivo principale e
che il Filieri ad esse si riferisca dimostra che quella dei moduli oltre
che una sua proposta è una tendenza diffusa e convalidata, della quale
“Le ali di Hermes” costituisce un attestato da tener sempre presente per
l’esemplarità dei contenuti, la ricchezza dei documenti e la chiarezza
espositiva. |