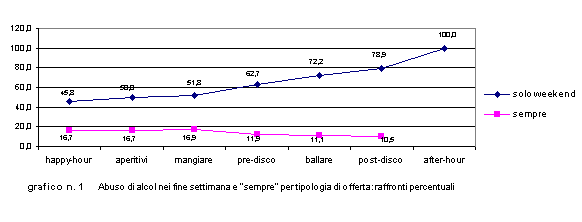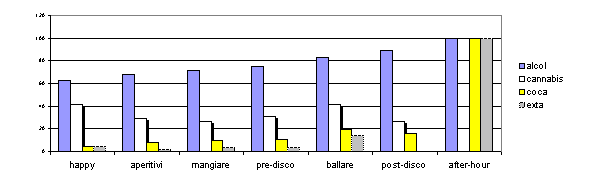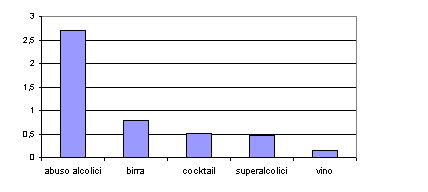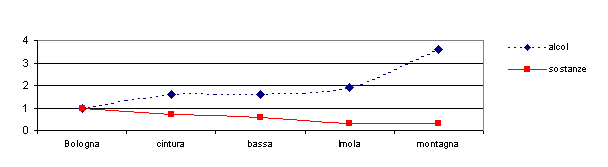|
|
|
|
Rave party: l'80% di chi vi partecipa si ubriaca almeno una volta a settimana; su un'età media di 24 anni, tutti usano droghe da 8 anni; il 50% ha avuto problemi a causa della droga. I dati dell'Osservatorio epidemiologico di Bologna.
BOLOGNA - Quasi l'80% si ubriaca almeno una volta alla settimana. A unetà media di 24 anni, tutti hanno dichiarato di usare droghe da circa 8 anni. Il 50% ha avuto problemi, negli ultimi tre anni, a causa del consumo di droghe. I dati arrivano dallOsservatorio epidemiologico metropolitano dellAzienda Usl di Bologna, che ha condotto una ricerca sul popolo dei raver, in occasione dello Street Rave Parade dello scorso 21 giugno. Le interviste ai giovani in tutto 375 - sono state raccolte durante i giorni della manifestazione, in collaborazione con il centro sociale Livello 57 che ogni anno organizza la parata antiproibizionista: si tratta quindi precisano dallOsservatorio di un campione del tutto particolare, e non rappresentativo dellintero mondo giovanile né dei consumatori occasionali. Il campione è formato da una minoranza di ragazze (33,9%), mentre letà media è di 24,2 anni, la metà dei ragazzi non abita in provincia di Bologna, il 7,5% è straniero e il 61% lavora. La principale riflessione emersa, analizzando i dati, è che il raver mescola alcol e sostanze in maniera acritica, e negli ultimi tre anni ha avuto problemi (arresti, denunce, ricoveri, incidenti), legati al consumo di queste sostanze. Un consumo acritico, sottolineano dallOsservatorio, perché nella maggior parte dei casi regna lignoranza sugli effetti di ciò che si assume. Se si guarda alle droghe che vengono consumate in relazione alletà spiegano i ricercatori - sembra che vi sia una ricerca dei diversi effetti delle sostanze: si comincia dai cannabinoidi, a 15 anni, e nel giro di cinque anni si passa a sperimentare sostanze che danno allucinazioni (Lsd, funghi, salvia divinorum), fino ad arrivare a sostanze che aumentano le performance psicofisiche (anfetamina, cocaina), per finire a sostanze che alterano o hanno effetti sedativi (alcol, oppio, eroina e morfina, per esempio). I ragazzi, poi, comprano e assumono sostanze di cui non sanno nulla, che associano ad alcol o a psicofarmaci, oppure usano droghe per contrastare o amplificare gli effetti di altre droghe. Ed è proprio la curiosità, secondo la ricerca, a spiegare il fenomeno del policonsumo: se infatti il 30% degli intervistati si ferma alluso dei cannabinoidi, il 15% aggiunge allo spinello unaltra sostanza e il 55% più di una sostanza. I profili più preoccupanti sono quelli di chi mischia alcol e droga, consuma più sostanze, è inesperto e mosso dalla voglia di provare. La dimensione dellabuso tra i giovani, e soprattutto le modalità e i significati attribuiti allesperienza del consumo (curiosità, divertimento, socializzazione) non consentono più di considerare labuso di droghe un comportamento esclusivamente deviante, ma inducono a vederlo come parte dello scenario della società giovanile.
Fonte: Relazione annuale al Parlamento sullo stato delle tossicodipendenze in Italia, 2002
Fonte: Relazione annuale al Parlamento sullo stato delle tossicodipendenze in Italia, 2002
Fonte: Relazione annuale al Parlamento sullo stato delle tossicodipendenze in Italia, 2002
A cura di
Raimondo Maria Pavarin Michelina Ruo Fabiana forni
Presentazione a cura di Luisa Prata*
I SerT di Bologna sono fortemente orientati impegnare tempo e risorse nella cura e riabilitazione delle persone che hanno sviluppato una tossicodipendenza da eroina e, in subordine, da alcol, mentre le attività di prevenzione, specie negli ultimi anni, hanno ricevuto un minore impulso anche nel timore di mettere in campo azioni sporadiche e poco efficaci Nellambito dei servizi di cura, però, si è rilevato che una percentuale significativa di tossicodipendenti consuma anche sostanze diverse dalla droga di elezione. Alcune di queste sostanze variano nel tempo in ragione dellofferta prevalente sul mercato: in passato, si trattava soprattutto di farmaci (benzodiazepine a breve emivita); negli ultimi anni si è diffuso il consumo massiccio di cocaina, assunta per via endovenosa con effetti devastanti fisici, mentali e sociali. Altre sostanze, come alcol e cannabinoidi , sono presenti da sempre e il loro consumo accompagna in varia misura lassunzione di eroina. Fonte di particolare preoccupazione è oggi il consumo di cocaina, la cui pericolosità è spesso sottovalutata. Nonostante il fatto che si rivolgano ai servizi solo pochi cocainomani primari, la presenza di questi in carcere, la diffusione del consumo di cocaina tra gli eroinomani, le operazioni di polizia indicano una larga diffusione di questa ed altre sostanze in contesti e tra gruppi di popolazione non facilmente accessibili e poco noti ai servizi. Lèquipe del SERT in carcere, in particolare, segnala da tempo la presenza di un numero consistente di detenuti per reati connessi direttamente o indirettamente a droghe diverse dalleroina. Si tratta di persone con caratteristiche personali e sociali del tutto differenti da quelle del tossicodipendente da eroina, ma che hanno altrettanto bisogno di cure specifiche e di riabilitazione e che, soprattutto, entrano in contatto con i servizi solo quando il rapporto con le droghe ha prodotto nella loro vita danni gravi e spesso irreversibili. Oltre al carcere, in cui si entra in contatto con situazioni che hanno raggiunto livelli di gravità estrema, i punti di osservazione disponibili a livello locale su questo fenomeno sono diversi: le segnalazioni della prefettura che spesso si riferiscono a persone in condizioni di alto rischio, alcuni servizi con caratteristiche specifiche o sperimentali (gli Spazi Giovani a Bologna, alcuni servizi in provincia, alcune esperienze di accoglienza del privato sociale). Si tratta in genere punti di vista parziali, in grado di osservare singoli aspetti del fenomeno, noto come nuove droghe, che suscita un grave allarme sociale. Inoltre, le diverse rilevazioni e osservazioni di rado trovano modo di confrontarsi per costruire un quadro dinsieme credibile. Quali siano le dimensioni reali, la diffusione e la gravità del fenomeno resta quindi campo per ipotesi e congetture. La ricerca sui consumi giovanili in ambiti ricreativi notturni consente di accrescere le nostre conoscenze sul mondo dei poliassuntori e dei giovani consumatori di droghe sintetiche partendo dal presupposto che non sono tanto nuove le sostanze assunte, quanto lo sono gli scenari e i gruppi di popolazione coinvolti, le motivazioni al consumo e gli effetti ricercati, i rischi personali e sociali connessi. Obiettivo della ricerca è quello di cominciare a quantificare - a partire da contesti di osservazione privilegiati, i locali notturni, e utilizzando come osservatori gli stessi gestori dei locali - la diffusione del consumo di sostanze legali e illegali nel mondo giovanile, di identificare eventuali fasce di consumatori più esposti a rischi personali e sociali, di costruire una rete di collaborazione tra operatori socio-sanitari e addetti al lavoro notturno che consenta un monitoraggio costante del fenomeno. La ricerca può quindi diventare uno strumento importante per i servizi sanitari e sociali da un lato per programmare la formazione degli operatori perché la loro opera sia sempre più adeguata alle esigenze di unutenza che cambia e, dallaltro lato, per definire azioni di prevenzione mirate ed efficaci. *Direttore dellUnità Operativa Dipendenze Patologiche SERT AUSL Città di Bologna
Presentazione
a cura di Mila Ferri*
Da tempo la Regione Emilia-Romagna incentiva e sostiene attivamente politiche volte alla prevenzione del consumo di sostanze psicoattive allinterno dei luoghi di divertimento; nel 1997 la Giunta regionale approvò il Progetto nuove droghe che forniva direttive ai servizi del territorio in tema di prevenzione e riduzione dei rischi. Da allora la progettualità dei servizi pubblici e privati regionali si è andata sempre più orientando verso interventi modellati sul contesto allinterno del quale il consumo avviene. E evidente infatti come il mondo del divertimento notturno costituisca un ambiente peculiare, allinterno del quale il consumo di sostanze vecchie e nuove assume una valenza strettamente correlata alla fruizione del divertimento stesso. Qualsiasi intervento diretto a questo contesto deve essere basato su una conoscenza approfondita e non episodica della situazione, in altre parole, su un monitoraggio che consenta di adattare le proposte anche ai rapidi mutamenti che il fenomeno può presentare. Si può citare lesempio del divertimentificio proposto dalla riviera romagnola. Fino a qualche tempo fa i problemi correlati al consumo di sostanze legali ed illegali (in primis gli incidenti stradali alcol e droga correlati) venivano segnalati soprattutto allinterno e alluscita delle discoteche; ora si assiste ad un proliferare di disco-pubs, happy-hours e disco-bagni sulla spiaggia, con orari ovviamente diversi, frequentati da persone che proseguono la nottata in discoteca, ma anche da alcuni che terminano così la propria serata e si mettono alla guida in condizioni spesso non idonee. La progettualità dei servizi si è modificata di conseguenza, prevedendo interventi in questi ambienti che presentano caratteristiche molto diverse dalla discoteca tradizionale e richiedono pertanto un approccio differente. Ovviamente qualsiasi intervento allinterno del mondo del divertimento non può non prevedere un coinvolgimento dei gestori dei locali, nella consapevolezza che lobiettivo degli uni (ricavare un profitto dallattività commerciale) può essere coniugato con quello degli altri (tutela della salute dei frequentatori dei locali stessi). Da parte dei servizi deve esserci uno sforzo diretto a rendere il proprio intervento compatibile, e non in contrasto, con il locale allinterno del quale avviene. Credo che il progetto qui presentato riassuma bene la filosofia sopraesposta: monitorare il consumo nei contesti del divertimento, utilizzando operatori qualificati, in collaborazione con i gestori dei locali, per rendere disponibile un mappatura costante che orienti la rete dei servizi nella messa a punto della progettualità. E pertanto con piacere che ho aderito alla richiesta degli autori di presentare questa pubblicazione. Particolarmente interessante mi pare lidea di rendere routinaria questa rilevazione, con una reportistica semestrale, in grado sicuramente di divenire punto di riferimento per tutti coloro che hanno interesse alla progettazione. Ringrazio quindi gli autori per aver reso disponibile e fruibile il loro materiale.
*dirigente area Dipendenze, Assessorato Politiche sociali, Regione Emilia-Romagna
Introduzione
Il settore delle dipendenze attraversa una fase di profonda evoluzione per quanto riguarda sia il contesto epidemiologico sia la riorganizzazione dellassistenza. Ai problemi legati al carattere illegale e sommerso degli stili di consumo, si aggiungono quelli relativi alla diversificata composizione delle sostanze immesse sul mercato, ai mutamenti della popolazione dedita allabuso, relativi ai diversi soggetti che intervengono nel settore ed ai differenti compiti ed attività che svolgono. Le cause di morte legate allabuso di alcol ed al consumo di oppiacei, assieme agli incidenti stradali ed ai suicidi sono quelle per le quali tra le giovani generazioni cè il maggior rischio di mortalità. In particolare si stima una diretta responsabilità dellalcol in almeno la metà degli incidenti stradali ad esito invalidante ed un rischio elevato di decesso per gli assuntori di sostanze stupefacenti per tutte le cause di morte (in particolare overdose e AIDS). Tra i giovani luso sperimentale di alcol e di droghe è in gran parte collegato alla curiosità, a comportamenti e stili di vita di tipo imitativo allinterno del gruppo, alla reperibilità, ad occasioni favorevoli ed è spesso associato a momenti di socialità e di divertimento. Numerose ricerche hanno documentato come la maggior parte di coloro che hanno usato droghe almeno una volta nella vita lo abbiano fatto per sperimentarle o per un periodo di tempo limitato in gioventù (consumatori alle prime esperienze). I rischi di uso continuativo più elevati si sono osservati per luso di tabacco (circa la metà di chi ha fumato una volta continua a fumare) e soprattutto per lalcol, sostanza che almeno tre quarti dei giovani continuerà ad utilizzare. Invece i tassi relativi alluso continuato di droghe illecite sono considerevolmente inferiori (sotto il 20%). Per questi giovani il rischio è collegato alla possibile futura dipendenza e ad eventi occasionali associati ad alterazione (incidenti) o inesperienza (overdose). Esiste unaltra fascia di soggetti ad alto rischio che consumano o abusano in modo occasionale o in circostanze particolari (consumatori occasionali). Tali soggetti solitamente non si rivolgono ai servizi pubblici o privati sulle dipendenze o perché non li considerano un punto di riferimento utile e in grado di rispondere ai propri bisogni e non sono disponibili ad intraprendere terapie impegnative né ad interrompere luso di sostanze psicoattive, o perché in quanto consumatori occasionali non si considerano dipendenti da una qualche sostanza. Per tali soggetti il contatto con i servizi avviene in circostanze casuali (segnalazione come consumatori da parte delle forze dellordine ai Nuclei Operativi Tossicodipendenze della Prefettura) o in seguito ad accadimenti traumatici. Queste due categorie di consumatori, alle prime esperienze e occasionali, rappresentano una quota consistente di quel sommerso nel mondo delle dipendenze che risulta a rischio per epatopatie, patologie infettive, incidenti stradali, mortalità acuta e traumatica. Negli ambienti di vita notturna luso di sostanze psicoattive è spesso causato dallintenzione di divertirsi. Ridurre i rischi che un numero crescente di giovani corre facendo uso di tali sostanze nei locali notturni, è una questione prioritaria per i responsabili delle politiche sia a livello locale che a livello nazionale. Secondo lOsservatorio Epidemiologico Europeo sulle Dipendenze emerge che circa 50 milioni di persone negli stati dellUnione Europea hanno provato una droga illecita in qualche momento della propria vita. Nella popolazione compresa tra 15 e 64 anni almeno il 7% ne ha fatto uso nel corso dellultimo anno. Il consumo di stupefacenti tra i frequentatori degli ambienti di vita notturna è molto più elevato rispetto al resto della popolazione, tra questi si riscontra una netta prevalenza di giovani relativamente benestanti, che abitano in centri urbani, per i quali il consumo di stupefacenti si combina con quello di alcolici. Le indagini condotte sulla popolazione giovanile mostrano che letà media di prima assunzione (anche della cannabis) è solitamente attorno ai 18 anni e che i tassi di prevalenza più elevati si trovano tra i ragazzi che hanno finito o abbandonato la scuola (20/24 anni). Questo vale soprattutto per le droghe diverse dalla cannabis, soprattutto ecstasy, cocaina, eroina. Lalcol resta comunque la sostanza psicoattiva utilizzata con maggior frequenza e diffusione a scopo ricreativo. Le ragioni principali di chi fa uso di ecstasy sono collegate al ballo ed al maggior divertimento. In generale le droghe ricreative vengono assunte anche allo scopo di aumentare la fiducia in sé stessi e le proprie energie o ancora per provare nuove esperienze. Da non trascurare un altro dato che desta preoccupazione e cioè la percezione dellaumento della diffusione della cocaina. La disponibilità dellofferta, associata con limmagine di mondanità che riflette, evidenzia come in certi ambienti di vita notturna questa sostanza stia gradatamente sostituendo lecstasy.
Vi sono in letteratura numerosi studi che documentano le abitudini dei fautori del divertimento notturno (il popolo della notte), ma non viene utilizzata nelle sue potenzialità lesperienza di chi offre questo servizio. I gestori dei locali godono di un punto di osservazione privilegiato che consente di notare la presenza di nuovi consumi, i comportamenti legati alluso di sostanze e allabuso di alcolici. Dentro una logica di Sanità Pubblica diviene necessario conoscere in tempo utile la presenza di uovi tipi di abuso, la disponibilità di nuove sostanze, le circostanze in cui tali fenomeni possono incorrere in comportamenti a rischio, i percorsi che portano allabuso. Ciò determina la necessità di una progettazione di sistemi informativi integrati orientati alla conoscenza immediata delle problematiche emergenti sul territorio ed alle caratteristiche specifiche dei soggetti a rischio, dove al rigore metodologico va sommata lattivazione di interventi mirati. Lattività di ricerca sui comportamenti a rischio parte dalla necessità di conoscere e comprendere le problematiche delluniverso giovanile correlate allabuso di alcol e alluso di sostanze prima che sfocino in comportamenti devianti, danni alla salute, dipendenza. Questo studio in particolare intende monitorare e conoscere i consumi relativi al mondo della notte, le varie tipologie di locali, il tipo di divertimento che si offre, le abitudini di frequentazione, i target e le nuove tendenze a partire da interviste effettuate ai gestori. Obiettivo specifico è lapertura di una finestra costante sul mondo notturno giovanile, in particolare per quanto riguarda i frequentatori dei locali della città di Bologna e dei comuni della provincia. Viene posta particolare attenzione nellindividuare fasce di soggetti con potenziali comportamenti di abuso alcolico e di consumo di sostanze stupefacenti, anche tra loro combinati. La proposta in itinere è la costruzione di una rete con i gestori dei locali per individuare in tempo reale problematiche emergenti e modificazioni nei comportamenti a rischio, allo scopo fornire in tempo utile un riferimento oggettivo per chi deve progettare interventi di prevenzione.
Il progetto
Obiettivi. Lobiettivo del progetto (finanziato dal Ministero della Salute) è quello di costruire un sistema di monitoraggio in grado di reperire informazioni sui comportamenti giovanili rispetto ai consumi di sostanze stupefacenti e alcol e che permetta di creare una rete di collaborazione tra istituzioni e gestori per far fronte al fenomeno e individuare le migliori strategie preventive. Si ipotizza la creazione di un osservatorio sulle nuove tendenze e sui fenomeni di consumo a partire dai luoghi in cui essi si verificano. Questo implica:
Descrizione. La realizzazione di tale sistema di monitoraggio ha richiesto una fase iniziale di mappatura del territorio durante la quale sono stati individuati i locali notturni onde avere una panoramica generale dei luoghi di frequentazione giovanile. Successivamente si è proceduto alla costruzione del questionario e sono stati contattati i gestori dei locali, ai quali è stata richiesta una collaborazione per la compilazione. I risultati dellindagine saranno immessi allinterno del sito web dellOsservatorio (www.ossdipbo.org), per essere così fruibili da più addetti ai lavori. Il monitoraggio avrà cadenza semestrale, in concomitanza col cambio di stagione. Questo permetterà di rilevare eventuali variazioni dovute ai passaggi stagionali. Lobiettivo finale è la costruzione di una rete tra operatori e gestori, utile per la progettazione di eventuali interventi. La durata del progetto è triennale.
Esiti attesi · aumento della conoscenza rispetto al fenomeno nuove droghe · coinvolgimento attivo dei gestori nel monitoraggio e costruzione di una banca dati · aumento della conoscenza rispetto alle realtà giovanili e alle nuove tendenze · aumento della conoscenza sulla realtà dei locali notturni: orari, tipologie, target dutenza, numero · creazione di una partnership significativa sul territorio tra operatori ed addetti ai luoghi dellintrattenimento notturno rispetto alle tematiche delluso e del consumo delle sostanze · progettazione di interventi ad hoc da effettuarsi in collaborazione tra varie risorse presenti sul territorio.
Materiali e metodi
Individuazione dei locali pubblici ad alta frequentazione giovanile Per individuare i locali presenti sul territorio di Bologna e provincia sono state utilizzate diverse fonti. In primo luogo è stato contattato lUfficio Registro Imprese della Camera di Commercio della Regione che ha fornito un elenco complessivo di tutti i pubblici esercizi con somministrazione di alimenti e bevande della provincia di Bologna (oltre 600 locali). Successivamente sono state contattate le strutture dei comuni della provincia e dei quartieri di Bologna che si occupano di giovani (uffici alle politiche giovanili, uffici scuola), gli uffici della polizia amministrativa e addetti al rilascio delle licenze. Inoltre sono stati utilizzati come ulteriore fonte di informazione i siti internet, le guide alla città e alla provincia, le pubblicazioni di tipo pubblicitario e divulgativo, le testate nazionali che si occupano specificamente del mondo della notte e i quotidiani. Dallinsieme dei locali di cui si è venuti a conoscenza si è operata una prima scrematura selezionando i locali con apertura serale, quindi si sono raccolti in un database i dati relativi a 451 pubblici esercizi che potevano risultare a frequentazione giovanile (tipologia di locale, telefono, indirizzo, sito web, periodo apertura, giorno chiusura). Per la definizione della tipologia dei locali sono state prese in considerazione le diciture con cui comunemente vengono pubblicizzati, gli elenchi forniti dalla Camera di Commercio che definiscono il tipo di licenza e gli elenchi della FIPE (Federazione Italiana Pubblici Esercenti) che risultano i più aggiornati sulle nuove definizioni di locali serali-notturni. Sono state individuate le seguenti tipologie:
q locali di spettacolo (dancing, discoteca, night-club) q pubblici Esercizi classici (gastronomia, cocktail-bar, pizzeria, enologia, birreria) q pubblici Esercizi con attività culturali/espositive (letteratura, poesia, advertising, mostre darte, fashion, fumetto, illustrazione fotografia) q pubblici Esercizi con attività di spettacolo (live music, teatro, danza, cabaret, streap-tease, discopub, performance) q circoli privati (gastronomia, spettacoli, gioco) q centri sociali (anziani, giovanili)
Si è osservato che alcune delle diciture della Camera di Commercio non corrispondevano alla reale tipologia di servizio e di offerta, pertanto si è raggruppato e ridotto il numero delle tipologie che alla fine sono risultate le seguenti:
q bar q pub q birreria q discoteca q circolo q osteria q centro sociale q disco-pub q sala giochi q cocktail-bar q enoteca q ristorante
La mappatura Il passo successivo è stato quello di selezionare e individuare i locali interessanti per la ricerca, cioè quelli ad effettiva frequentazione giovanile. A tale scopo sono stati presi in esame i modelli di osservazione partecipante presenti in letteratura e si sono adattati al contesto serale notturno. Si è utilizzata una griglia di osservazione su modulo di raccolta dati cartaceo testata preliminarmente su alcuni locali. Losservazione è stata effettuata da due ricercatori (operatori della notte) che permanevano allinterno del locale per almeno unora. Seguendo i principi metodologici dellosservazione partecipante i due ricercatori hanno partecipato in prima persona alla serata, consumando anche qualcosa ed entrando nel vivo dellatmosfera del locale. Le osservazioni sono state raccolte in modo standardizzato utilizzando un modulo di raccolta dati cartaceo. I locali sono stati suddivisi in due fasce: una pre-serale/serale e una notturna. Losservazione nei locali serali avveniva tra le 19,00 e le 22,00 circa, mentre nei locali notturni tra le 22,00 e le 3-4,00 del mattino. Attraverso la griglia di osservazione sono state raccolte informazioni sulla tipologia di offerta rispetto al consumo e ad altri servizi (giochi, internet, ecc), caratteristiche dei consumi di bevande e alimentari, target (età, sesso, presenza di gruppi particolari come studenti, stranieri, gay), periodo di apertura (estivo, invernale), generi musicali, morfologia (luci, angoli bui, arredi), presenza/assenza di servizio dordine, presenza/assenza di controllo accessi, presenza di gruppi allesterno. La selezione dei locali interessanti ai fini della ricerca si è basata su un punteggio finale assegnato ad ogni locale dal ricercatore con un criterio soggettivo (da 1=poco interessante a 10=molto interessante). Nellassegnare il punteggio si è tenuto conto di alcuni aspetti, in particolare del tipo di target (se giovanile) e della sua numerosità. I locali che hanno ottenuto un punteggio di almeno 6 punti sono stati ritenuti interessanti da esaminare successivamente con una intervista. Con questo metodo sono stati individuati 135 locali ad alta frequentazione giovanile.
Lo strumento di rilevazione: costruzione del questionario Il questionario è stato costruito coinvolgendo alcuni allievi del corso di formazione per Operatori della notte organizzato dal Comune di Bologna Progetto città sicure, utilizzando una tecnica qualitativa di Policy Analysis, il Nominal group thecnique. Il metodo si basa sulla separazione dellidea dallideatore in modo da separare i criteri di giudizio dallinfluenza di rapporti personali e/o gerarchici. Inizialmente è stato effettuato un brain storming per individuare le variabili da indagare. Successivamente utilizzando il nominal group thecnique sono stati individuati gli aspetti più importanti e di facile rilevazione.
Lo studio pilotaPer verificare la fattibilità del progetto nel corso del 2000 è stato disegnato uno studio pilota con interviste ai gestori di 13 locali pubblici della città di Bologna: 6 pubs, 4 circoli, 2 centri sociali, 1 discoteca. Leffettuazione delle interviste in questa fase ha permesso di verificare la disponibilità dei gestori a collaborare al progetto, e apportare le opportune modifiche allo schema del questionario iniziale semplificando gli items e codificando le risposte. E stato così approntato un nuovo questionario più semplice e completo che è stato utilizzato in questo lavoro.
Il questionario finale Il questionario finale è strutturato su 11 variabili a risposte chiuse. Nello specifico: giorno di chiusura, giorno di maggior affluenza, tipologia del locale (a risposte multiple - bar, pub, birreria, discoteca, circolo, osteria, centro sociale, disco pub, sala giochi, cocktail bar, enoteca, ristorante), capienza (posti a sedere, posti in piedi), età in classi degli avventori (prodotta in percentuale distinta per maschi e per femmine), target (risposte multiple - studenti, gay, stranieri), presenza di stranieri (risposte multiple - occidentali, magrebini, africani, latinoamericani, asiatici), tipo di fruizione (risposte multiple aperitivi, happy hour, pre discoteca, post discoteca, ballare, after hour, mangiare), generi musicali proposti , controlli (servizio dordine, controllo accessi), abuso alcolici (dentro o fuori dal locale, tipo di alcolico e giorno della settimana), consumo sostanze (dentro o fuori dal locale, tipo di sostanza e giorno della settimana).
Le interviste ai gestori Il contatto con i gestori è avvenuto previo appuntamento telefonico. In alcuni casi è stato necessario un lavoro preventivo (colloquio) per specificare meglio obiettivi e contenuti dellindagine e abbattere ostilità e diffidenze. In alcuni casi i gestori esprimevano una forte insoddisfazione nei confronti dellamministrazione pubblica, per cui si è cercato di contenere il disagio. In altri casi vi era la necessità da parte loro di comprendere bene gli obiettivi del progetto ed è stato necessario specificare ulteriormente gli intenti. Solo in alcuni casi le interviste sono state ottenute senza difficoltà. E stato quindi necessario un lavoro preventivo a livello relazionale: prima di effettuare lintervista venivano chiariti contenuti e obiettivi del progetto, veniva consegnata una lettera di presentazione dellAzienda, si garantiva lanonimato evidenziando che i dati raccolti sarebbero stati divulgati in forma aggregata, si specificava che ci sarebbe stato un ritorno informativo in termini di analisi di mercato. Lintervista è stata effettuata da un ricercatore esperto (operatore della notte) e mediamente ha avuto una durata di 30 minuti con una certa variabilità che è stata determinata soprattutto dal lavoro di relazione con i gestori. Dopo la prima serie di interviste ai gestori è stato inviato un rapporto specifico (indagine di mercato) relativamente alle caratteristiche dei frequentatori (classi di età e sesso per tipologia di locale) e dei locali (tipologie di offerta per tipo di locale, giorni chiusura, giorni maggior affluenza). Per le analisi dei dati è stato utilizzato il software per lanalisi epidemiologica STATA 7.0; il database è stato gestito con SPSS 10.0.
La validità del questionario Per misurare laffidabilità di una misurazione bisogna escludere linfluenza di effetti sistematici (distorsioni) a carico di una o più misure. A tale scopo è stato disegnato un apposito studio nel quale sono stati confrontati i risultati relativi alluso di sostanze ed allabuso di alcol ottenuti con due metodi diversi. In 15 locali, scelti con campionamento stratificato per tipologia di locale e per zona, nel mese di novembre 2002 sono stati intervistati i gestori. Nello stesso periodo un ricercatore appositamente addestrato utilizzava la tecnica dellosservazione partecipante per rilevare uso di sostanze e abuso di alcolici. La concordanza tra i due metodi è stata calcolata con il test Kappa di Cohen confrontando i risultati delle interviste con i dati raccolti attraverso losservazione partecipante. Lindice statistico K è una misura della riproducibilità più valida del semplice accordo osservato in quanto tiene conto anche dellaccordo dovuto alleffetto del caso. I valori soglia del test sono sopra il 50%.
Utilizzando il test separatamente per il solo abuso di alcol, in 11 locali labuso è osservato sia dai gestori che dal ricercatore, in 3 è rilevato solo dal ricercatore, in 1 solo dal gestore. Labuso di alcol è sottostimato dallintervista ed il test risulta negativo.
Utilizzando il test separatamente per il solo uso di sostanze, in 8 locali vi è accordo di assenza, in 5 di presenza, in 2 è notato solo dal ricercatore. Il test risulta positivo (0.73 livello soglia 0.50) anche se luso di sostanze è sottostimato dai gestori.
Considerando i valori complessivi del test, lintervista condotta col questionario si può considerare uno strumento valido ed affidabile ed i risultati che produce sottostimano il consumo di alcol. In particolare il consumo di alcol viene sottostimato nel 20% dei locali e luso di sostanze nel 13%. Ciò può essere in parte ricondotto al mestiere dei gestori (vendono alcolici) che li porta a sottovalutare i rischi (abuso) che la loro attività comporta.
Nota in merito al termine abusoPer quanto riguarda labuso si specifica che tale termine non vuole necessariamente dire ubriachezza per gli alcolici o overdose per le sostanze stupefacenti. Si specifica inoltre che uso è molto diverso da abuso. Il concetto di abuso non è stato preliminarmente definito ai gestori ma si è lasciata libertà di interpretazione dentro una valutazione soggettiva dettata dallesperienza. Spesso i gestori hanno chiesto delucidazioni su cosa si intendesse per abuso; è stato loro precisato di cercare di valutare lo stato di evidente alterazione dovuto allalcol.
Risultati
Dalla mappatura dei locali del territorio di Bologna sono stati individuati 135 locali risultati interessanti per lindagine. Tramite interviste strutturate a risposte chiuse effettuate ai gestori si sono raccolte informazioni relative ai locali e informazioni relative ai fruitori sulluso di sostanze stupefacenti e abuso di alcolici. Si è lasciata libertà di interpretazione ai rispondenti dentro una valutazione soggettiva dettata dallesperienza e dallosservazione diretta. Le informazioni raccolte si riferiscono a 114 locali su 135, cioè al totale dei gestori che hanno effettuato lintervista (80% sul totale). In particolare 8 locali erano chiusi e 13 gestori hanno rifiutato di collaborare.
Area territoriale e popolazione di riferimento I locali a frequentazione giovanile individuati sul territorio di Bologna e provincia sono stati raggruppati in 5 zone territoriali. Tale raggruppamento è stato realizzato utilizzando un criterio socio-geografico che comprendesse i vari comuni in base a urbanizzazione dellarea e caratteristiche morfologiche del territorio. Le zone individuate sono:
1. città di Bologna 2. città di Imola 3. la zona denominata Cintura Bolognese che include i paesi dellhinterland: Zola Predosa, S. Lazzaro, Ozzano, Castenaso e Casalecchio di Reno 4. la zona denominata Appennino (caratterizzata dalla più bassa densità di popolazione e la più alta età media) che include i paesi situati sullAppennino tosco-emiliano e sono: Bazzano, Borgo Tossignano, Camugnano, Casalfiumanese, Castel DAiano, Castel del Rio, Castel di Casio, Castello di Serravalle, Castiglione dei Pepoli, Crespellano, Dozza, Fontanelice, Gaggio Montano, Granaglione, Grizzana Morandi, Lizzano in Belvedere, Loiano, Marzabotto, Monte S. Pietro, Monghidoro, Monterenzio, Monteveglio, Monzuno, Pianoro, Porretta Terme, S. Benedetto Val di Sambro, Sasso Marconi, Savigno, Vergato 5. la zona denominata Bassa Bolognese comprende i comuni della pianura e include Anzola dellEmilia, Argelato, Baricella, Bentivoglio, Budrio, Calderara di Reno, Castelguelfo, Castello dArgile, Castel S. Pietro Terme, Crevalcore, Galliera, Granarolo, Malalbergo, Medicina, Minerbio, Molinella, Pieve di Cento, Sala Bolognese, S. Giovanni in Persiceto, S. Pietro in Casale, S. Agata Bolognese, Mordano, S. Giorgio di Piano.
La popolazione generale di riferimento con unetà compresa tra 15 e 39 anni è così distribuita: 117.396 giovani a Bologna città; 20.935 giovani nella zona di Imola; 32.842 nellarea denominata cintura bolognese, 28.342 soggetti nellarea appenninica; 76.124 zona della pianura.
Tipologia dei locali e caratteristiche I locali sono stati classificati nelle seguenti tipologie che descrivono lutilizzo prevalente: bar, pub, birreria, discoteca, circolo (locali in cui occorre avere una tessera per entrare), osteria, centro sociale, disco-pub, sala giochi (luoghi del divertimento in cui sono presenti anche una o più sale giochi), cocktail-bar, enoteca, ristorante (risto-ballo, dove è possibile mangiare e trovare poi occasione di divertimento con musica e ballo dopo la cena). Lofferta che si ritrova è spesso associata cronologicamente ai diversi momenti del divertimento e ritrovo serali per cui i bar, cocktail bar ed enoteche diventano occasioni di incontro in prima serata per laperitivo o lhappyhour. I pub, birrerie ed osterie si configurano come momenti di socializzazione per la tarda serata magari prima di andare a ballare. Poi ci si dedica alle danze in discoteca, circoli, disco-pub o centri sociali. Infine dopo la discoteca si può continuare a ballare presso locali che organizzano after-hour fino al mattino, oppure ci si può preparare al sonno consumando la colazione o altro presso bar e pub. La maggioranza dei locali a frequentazione giovanile è, come ci si può facilmente aspettare, concentrata a Bologna città con un totale di 67 su 114 e rappresenta il 59% sul totale. A Imola ne sono stati individuati 9; 7 nella cintura Bolognese; 15 nellappennino e 16 nella bassa. Complessivamente lofferta è di un locale ogni 2418 giovani (popolazione target/numero locali). La concentrazione dei locali rispetto alla popolazione target vede una maggiore densità a Bologna (1 locale ogni 1752 giovani), seguita dalla montagna (1 locale ogni 1889 giovani), Imola (1 locale ogni 2326 giovani), cintura (1 locale ogni 4692 giovani), bassa (1 locale ogni 4758 giovani).
Tabella n. 1 Tipologia di locali per zona
Se osserviamo come la tipologia dei locali si distribuisce allinterno delle aree territoriali individuate si possono notare delle differenze tra le varie zone che richiamano la dicotomia città campagna e le diverse forme di aggregazione e socializzazione che ne derivano. Si può quindi pensare a occasioni di incontro e divertimento diverso tra la città e le aree periferiche. Questo può voler anche dire ad esempio che il divertimento può dare origine a un fenomeno di migrazione da parte dei giovani da unarea allaltra per cercare nuove e diverse occasioni di socializzazione che non sono presenti nella propria zona territoriale.
Tabella n. 2 Tipologia di locali per zona raffronti percentuali
A Bologna città essendo presenti il 59% dei locali troviamo una conseguente varietà dellofferta e la presenza più o meno numerosa di tutte le tipologie. Fatti cento i totali per area territoriale, i pub-birrerie sono più diffusi come luoghi di aggregazione giovanile nellarea della bassa, montagna e cintura. Le discoteche e i disco pub trovano una certa presenza nella zona della cintura, Imola e montagna. Le osterie ed enoteche sono maggiormente presenti a Imola e nella bassa. Per quanto riguarda i bar, nella zona montagna e bassa prevalgono come centri di aggregazione giovanile i bar tradizionali, mentre i cocktail bar, di più recente diffusione, li ritroviamo in misura maggiore a Imola, Bologna e zona cintura. I centri sociali invece sono presenti solo a Bologna città. Rispetto alla tipologia di offerta, che diventa poi anche motivo di incontro e socializzazione, nel 57.9% dei locali si consumano aperitivi, nel 21.1% si effettuano happy-hour, il 51.8% di essi viene frequentato come locale pre-discoteca, nel 31,6% si balla, il 16.7% sono locali post-discoteca, nello 0.9% si continua a ballare sino alla tarda mattinata (after-hour), nel 72.8% si può anche mangiare. Nella lettura dei dati riguardo alla tipologia occorre tenere presente che un locale può essere ricompreso in più tipologie perché lofferta è variegata.
Tabella n. 3 Tipologia di offerta per tipologia di locali: raffronti percentuali
(*) percentuali calcolate su un solo caso
Gli incontri per gli aperitivi, e quindi in prima serata, sono molto diffusi in bar e cocktail-bar, enoteche ed osterie e birrerie; per lhappy hour ci si incontra prevalentemente nei disco-pub e birrerie. Per il ballo, se il primato va alle discoteche e centri sociali, ci si incontra anche nei disco-pub, circoli e risto-ballo. Dopo la disco ci si incontra soprattutto nei pub, ma anche nei bar. I giorni di maggiore affluenza in tutti i locali si confermano il sabato e il venerdì. I giorni di chiusura più frequenti sono la domenica e il lunedì.
Abuso osservato di alcol Alla domanda se è stato notato un abuso di alcol i gestori hanno risposto si nel 23.7% dei casi (26 locali), talvolta nel 50% (57 locali). Aggregando le due modalità di risposta si osserva che labuso è stato notato in almeno il 73.7% dei locali. Labuso di alcol è stato maggiormente notato dai gestori di birrerie, enoteche, discoteche e cocktail bar. Viene notato talvolta dai gestori di pub, circoli, sala giochi e centri sociali.
Tabella n. 4 Percentuale di abuso di alcolici per tipologia di offerta
(*) percentuali calcolate su un solo caso
Rispetto al momento del divertimento e aggregazione sembra evidente che il maggior abuso di alcol, soprattutto cocktail e superalcolici, è molto legato alla situazione del ballo (tabella n. 4 e n 5). Inoltre viene notato un abuso di alcol anche nei posti in cui ci si incontra prima della discoteca e dopo. E possibile ipotizzare una modalità di consumo per tappe: si inizia la serata con happy-hour e aperitivi, poi si va a ballare e infine ci si trova per la colazione al mattino in probabile stato di alterazione. Si può rintracciare anche un altro percorso più tradizionale in cui prevale il consumo di vino: possiamo notare che esso viene consumato prevalentemente in osterie e bar come aperitivo (16.7%) e quando si è a cena fuori casa (14.5%). Viene allora da chiedersi se labuso di alcol nei vari giorni della settimana e nei vari momenti del divertimento serale è sempre uguale. Sembrerebbe di no. Infatti, come ci si può facilmente aspettare (andamento grafico n. 1), viene notato un maggior consumo di alcolici durante il fine settimana in 61 locali su 114. Quelli invece in cui il maggior abuso è notato anche durante la settimana sono 21. Bisogna comunque tenere presente nellinterpretazione di questo dato che i giorni di apertura e chiusura dei locali variano molto e alcuni di essi (come ad es. discoteche e centri sociali) sono aperti quasi esclusivamente il fine settimana. Possiamo quindi dire che vengono a configurarsi due tipologie di locali: quelli in cui è prevalente labuso di alcolici nel weekend, che sono la grande maggioranza, e quelli in cui labuso è osservato sempre. Anche rispetto ai vari momenti del divertimento serale si sono osservate rispetto a queste due tipologie differenti probabilità di riscontrare un abuso man mano che si avanza nelle ore della notte. Utilizzando come indicatore la suddivisione di una serata in varie momenti di incontro e divertimento che si succedono (rispetto allofferta dei locali è stata individuata questa successione: happy-hour, aperitivo, cena, pre disco, ballo, post disco, after-hour) landamento della probabilità di trovare un abuso di alcol durante il fine settimana segue un aumento lineare e progressivo man mano che si va dagli aperitivi verso tarda notte. Nei locali invece in cui labuso è osservato durante tutta la settimana il consumo di alcol segue un andamento opposto perché diminuisce man mano che si avanza verso le ore tarde. Inoltre anche la fruizione del divertimento si adegua ad un arco temporale più ristretto.
Alcune indicazioni utili si possono trarre anche dalla tabella n. 5. Osservando il tipo di bevanda di cui si nota un maggior abuso si conferma la plausibilità dellipotesi di un fenomeno che si sta caratterizzando a livello nazionale, e cioè la trasformazione negli stili giovanili del bere. La bevanda di cui i gestori notano un maggior abuso è la birra (44%); seguono cocktails (34%) e superalcolici (31.6%). Il vino è la sostanza alcolica di cui si osserva invece il minor abuso (13.2%). Nei locali in cui si può ballare (disco-pub, centri sociali e discoteche) è stato osservato, un maggior abuso di superalcolici.
Tabella n. 5 Abuso di alcol durante i fine settimana per tipologia di offerta raffronti percentuali
Si può parlare di affermazione di una cultura anglosassone nellutilizzare lalcol? E possibile fare una tale ipotesi. Gli studi in letteratura che utilizzano un approccio socio-culturale fanno riferimento a due modelli ideal-tipici del bere: un modello bagnato o mediterraneo ed un modello asciutto o anglosassone. Per spiegare i diversi atteggiamenti culturali nei confronti del bere che si possono trovare in questi due modelli viene preso in considerazione il valore duso che viene fatto delle bevande alcoliche e la funzione sociale del bere. Nei paesi produttori di vino (come ad es. i paesi mediterranei) è dominante il valore nutritivo alimentare dellalcol e il bere costituisce un elemento importante dellinterazione sociale. Per converso, nelle società dellEuropa centro-settentrionale, il primato è stato storicamente dato alluso inebriante dellalcol, bevanda di regola assente nella vita di tutti i giorni. A una cultura dellubriachezza propria del modello anglosassone si contrappone una cultura del bere propria del modello mediterraneo. A una cultura nella quale il valore duso principale è costituito dalleuforia si contrappone una cultura nella quale altri (ad esempio il nutrimento, la socialità, ecc.) sono i valori duso dominanti. Individuare il valore duso dominante in una data società, significa anche prendere atto del fatto che la struttura stessa degli atteggiamenti nei confronti delle bevande alcoliche ne risulta conseguente in quanto valori duso e atteggiamenti sono tra di loro legati. E chiaro infatti che, nella misura in cui domina luso dellalcol come mezzo per sballare, poca o nessuna differenza sarà riscontrabile tra atteggiamenti nei confronti del bere e atteggiamenti nei confronti dellubriachezza. Se il valore duso alimentare del vino non è dominante, il rischio di abuso alcolico aumenta perché si apre lo spazio al valore duso delleuforia. Da queste brevi considerazioni è possibile trarre alcune indicazioni utili per valutare la plausibilità dellipotesi che siano in corso trasformazioni negli stili del bere giovanili nella direzione del modello anglosassone. La modalità del bere giovanile si sta differenziando da quella degli adulti e questo mutamento in corso va esaminato allinterno dei cambiamenti più generali dei consumi alcolici e delle trasformazioni sociali in atto. Ladozione di un nuovo stile del bere comporta che le regole del come, del dove e del quanto, elaborate nei secoli dalla cultura mediterranea per il vino, siano certamente diverse da quelle in atto in contesti culturali dove si consumano tradizionalmente superalcolici e birra e dove leuforia costituisce il valore duso principale. Il nuovo modello di consumo può creare una situazione di assenza di regole nella quale trova spazio labuso non regolato. Il numero dei bevitori moderati cala mentre cresce quello dei bevitori pesanti. In particolare si riducono complessivamente tra i giovani i consumi di vino mentre aumentano quelli di birra e superalcolici. Da una ricerca effettuata dallESPAD sulluso di alcol, tabacco e sostanze illecite tra gli adolescenti e i giovani studenti tra i 15-19 anni è stato rilevato che lapprovazione delluso di alcolici o dei comportamenti di abuso di alcol, come lubriacarsi, mostrano negli anni dal 99 al 2001, un aumento significativo. I ragazzi che approvano il comportamento di ubriacarsi una volta alla settimana sono passati dal 18% del 1999 al 23% del 2001 e diminuisce la percentuale di quelli che disapprovano farlo. Contestualmente, diminuisce la percezione del rischio per la salute legato al bere. Si nota anche un incremento costante negli anni degli episodi riferiti di ubriachezza negli ultimi 12 mesi (dal 36% del 1995 al 41% del 2001).
Consumo osservato di sostanze stupefacenti Ai gestori è stato chiesto se avevano notato un consumo di sostanze stupefacenti dentro o fuori il locale. Il 6% (7 locali) ha risposto di si, il 29.8% (34 locali) talvolta. Aggregando le due modalità di risposta si osserva che luso è stato notato da almeno il 35.8% dei gestori e si configura principalmente come un uso osservato durante il fine settimana. La cannabis è la sostanza di cui principalmente viene notato luso (32.5%, 37 locali), seguita dalla cocaina (10.5%, 12 locali), dallextasy (5.3%, 6 locali), e dalleroina (1.8%, 2 locali).
Tabella n. 6 Consumo di sostanze per tipologia di offerta raffronti percentuali
(*) percentuali calcolate su un solo caso
Luso della cannabis è stato maggiormente notato dai gestori di centri sociali e circoli, ma anche disco-pub, bar, pub. Luso della cocaina ed extasy è stato maggiormente notato dai gestori di centri sociali, ma anche discoteche risto-ballo. Il grafico n. 2 mostra landamento della probabilità di osservare un consumo di sostanze man mano che lofferta di divertimento tende verso la notte. Si può notare un picco per tutte le sostanze (ovviamente in percentuali diverse) in corrispondenza con il momento del ballo. E evidente che lutilizzo di queste sostanze assume una valenza ricreazionale ed è associato allintenzione di divertirsi. Le sostanze ricreazionali infatti sono legate allaspetto socializzante e sono maggiormente associate alla componente del ballo e della musica. Da notare altre due cose interessanti osservando landamento del grafico: lalcol resta la sostanza psicoattiva di cui i gestori notano il maggior abuso e diffusione a scopo ricreativo; landamento della cocaina è assimilabile a quello dellecstasy ma con percentuali più elevate.
E quasi assente luso osservato di eroina. Questo è facilmente spiegabile con il fatto che il consumo di eroina è occulto, nascosto, legato più alla sfera strettamente privata che agli ambiti di socializzazione e del divertimento. Leroina non è da annoverare tra le sostanze usate a scopo ricreazionale.
Il rischio di abuso Per misurare il rischio è stato utilizzato lOdds Ratio, la stima cioè della probabilità di trovare abuso. Si calcola dividendo il numero dei locali in cui i gestori hanno notato abuso per quelli in cui non lhanno notato. Per esempio in 83 locali si nota abuso di alcol ed in 31 no: O.R.=83/31 cioè 2.70; in questo caso la probabilità di trovare abuso di alcol è quasi tre volte quella di non trovarne affatto. Per misurare la significatività statistica si sono calcolati gli intervalli di confidenza al 90%, cioè il range entro il quale collocare il valore trovato ed escludere leffetto del caso.
Il grafico n. 3 descrive la probabilità di riscontrare abuso di alcolici in generale ed in relazione al tipo di bevanda. La probabilità di trovare abuso di alcol nei locali oggetto dellindagine è molto elevata (O.R. 2.70), ma distribuita in modo diverso a seconda della bevanda. Il valore è più elevato per la birra (O.R. 0.78), seguita da cocktails (O.R. 0.52), superalcolici (O.R. 0.46) e vino (O.R. 0.15). Da notare che la probabilità di rilevare abuso di vino è in assoluto la più bassa: per la birra è 5 volte quella del vino, quella per cocktails e superalcolici il triplo.
grafico n. 4 O.R. uso sostanze stupefacenti
Il grafico n. 4 descrive la probabilità di notare uso di sostanze stupefacenti in relazione al tipo di sostanza. La probabilità di trovare uso di sostanze stupefacenti è in un locale su due (si= 41 no=73 O.R. 0.56), ed è dovuto in gran parte alluso di cannabis (O.R. 0.48). La probabilità legata alluso di cocaina (O.R. 0.12) è doppia di quella dellecstasy (0.06), luso di eroina è molto basso e viene notato solo in alcuni locali di Bologna (O.R. 0.02).
Nelle tabella n. 7 si riportano i risultati del modello multivariato relativamente alla probabilità di riscontrare abuso di alcol per zona geografica e per tipologia di offerta di divertimento. In tale modello i rischi relativi di ciascuna variabile sono aggiustati per tutte le altre. La categoria di riferimento per la zona è labuso nella città di Bologna: dove lO.R. è superiore a 1 significa che la probabilità di trovare abuso nella zona è più alta rispetto alla città, dove è inferiore a 1 significa che è più bassa. Per quanto riguarda la tipologia di offerta, essendo a risposte multiple, dove lO.R. è superiore a 1 significa che è molto più probabile il rischio di riscontrare abuso. Dove il dato è evidenziato in neretto significa che è statisticamente significativo, cioè che il valore trovato non è dovuto al caso. Nel nostro caso la probabilità di abuso di alcol viene aggiustata per zona e per tipologia di offerta, ciò significa, per esempio, che il dato relativo alla maggiore probabilità di abuso che si nota in montagna (O.R. 3.6) è calcolato tenendo conto anche di quella delle altre zone e dellofferta di divertimento; che il dato relativo alla maggior probabilità di abuso che si può trovare nei locali per ballare (O.R. 1.4) è calcolato tenendo conto dellofferta di divertimento dei locali e della zona in cui sono collocati.
Tabella n. 7 O.R. abuso alcol per tipologia di sostanza e x zona: regressione logistica multivariata
Si nota una probabilità statisticamente significativa di trovare abuso di birra nei locali post disco (O.R. 3.9), di cocktails nei locali per aperitivi (O.R. 3.0) e per ballare (O.R. 5.4). Nel dettaglio, per quanto riguarda labuso di alcolici, ed in particolare della birra, si nota una probabilità elevata nei locali della montagna, pre disco, per ballare e post disco. Labuso di cocktails si nota nei locali della bassa, negli aperitivi e per ballare. Labuso di superalcolici negli happy hour e nei locali dove si balla. Labuso di vino negli aperitivi, dove si mangia e dove si balla.
Nelle tabella n. 8 si riportano i risultati del modello multivariato relativamente alla probabilità di riscontrare uso di sostanze stupefacenti per zona geografica e per tipologia di offerta di divertimento.
Tabella n. 8 O.R. uso sostanze per tipologia di sostanza e x zona: regressione logistica multivariata
Si nota una probabilità statisticamente significativa di trovare uso di sostanze nei locali per ballare (O.R. 2.9). Luso di sostanze è meno frequente nei locali fuori Bologna e si nota anche negli happy hour e nei locali pre disco. La probabilità di riscontrare uso di cannabis è più frequente negli happy hour, nei locali pre disco e dove si balla. Per quanto riguarda lecstasy la probabilità è alta nei locali di Imola ed è maggiore dove si balla (O.R. 5.9). La probabilità di trovare uso di cocaina è più elevata nei locali della cintura, nei locali pre disco, dove si balla e nei post discoteca.
grafico n. 5 Probabilità di abuso di alcol e sostanze stupefacenti per Zona O.R.
Il grafico n. 5 descrive la probabilità di riscontrare abuso di alcol ed uso di sostanze stupefacenti rispetto alla zona in cui si trova il locale. La categoria di riferimento è la probabilità nella città di Bologna e assume il valore 1. Landamento delle probabilità è diverso per abuso di alcol e uso sostanze: per lalcol è più elevata man mano che ci si sposta nei locali fuori Bologna, quella di uso di sostanze è più bassa man mano che ci si sposta nei locali della provincia.
grafico n. 6 Probabilità di abuso di alcol e sostanze stupefacenti per Zona tipologie di locali - O.R.
Il grafico n. 6 descrive la probabilità di riscontrare abuso di alcol e uso di sostanze di stupefacenti rispetto alla tipologia dellofferta. Landamento del rischio sembra correlato allora della notte. Se ordiniamo le tipologie dei locali a seconda della fascia oraria di frequentazione notiamo come la probabilità di [1] Ð~POST http://phx1a.cp.virgilio.it/mail/babilità di uso di extasy aumenti sino allora del ballo, luso di cocaina aumenti sino allora del ballo per poi calare, la probabilità di uso di cannabis cali allora di cena, si riprenda durante il ballo e poi cali di nuovo. Le probabilità di uso di stupefacenti in assoluto più elevate si trovano durante il ballo, la probabilità di abuso di alcol aumenta anche dopo (post discoteca).
Alcune considerazioni
Le ricerche condotte sui giovani che frequentano i locali serali/notturni e sulluso che essi fanno di sostanze psicoattive mettono in evidenza le diversità di fondo tra questo target e gli utenti dei servizi pubblici e privati per le dipendenze: i soggetti consumatori di tali sostanze non appartengono alle fasce sociali più svantaggiate o alle frange dellemarginazione, ma vanno ricercati tra i giovani, gli studenti, gli impiegati, provenienti da categorie relativamente benestanti ed acculturate. Per questi giovani il rischio è collegato alla possibile futura dipendenza, ad eventi occasionali associati ad alterazione (incidenti) o inesperienza (overdose), e dal consumo a lungo termine. La maggior parte ne fa un uso ricreativo contestuale, soprattutto nei luoghi di divertimento, e probabilmente solo una minoranza sarà interessata da fenomeni di dipendenza cronica e da conseguenti problematiche di disagio psico-sociale ed esclusione tipici di alcolisti e tossicodipendenti. Se è vero che per quanto riguarda le droghe pesanti esiste un monitoraggio costante consolidatosi nel tempo grazie a ricerche, studi e sistemi informativi che nel loro assieme forniscono un quadro plausibile di questa realtà, altrettanto non si può dire del fenomeno nuove droghe, la cui conoscenza è limitata a studi descrittivi svolti in determinati contesti (discoteche, scuole) e condizionata da oggettivi problemi metodologici.
Nel nostro studio si sono presentati una serie di problemi tecnicamente rilevanti: lindividuazione dei locali a effettiva frequentazione giovanile, il rapporto coi gestori, laffidabilità delle risposte. Ognuno di questi fattori, se non controllato adeguatamente, può influire sui risultati, condizionandoli. Abbiamo cercato di ridurre le possibili distorsioni con una attenta mappatura dei locali, con un lavoro di relazione coi gestori, con lo studio di riproducibilità per valutare lattendibilità delle interviste. In particolare abbiamo appurato che i gestori tendono a sottovalutare labuso di alcol e che hanno una difficoltà oggettiva nellosservare luso di sostanze stupefacenti. Inoltre non siamo riusciti a stimare la numerosità dei soggetti a rischio (consumatori occasionali e alle prime esperienze) né a definirne le caratteristiche socio economiche.
I risultati che presentiamo confermano in parte quanto riportato in letteratura: luso frequente tra i giovani della cannabis, la modificazione avvenuta negli stili del bere giovanili e lalto rischio di abuso di alcol, sostanza utilizzata con maggior frequenza e diffusione a scopo ricreativo. La birra ed i superalcolici sono le bevande di maggior abuso tra i giovani. Luso di sostanze psicoattive risulta correlato a momenti di socialità e divertimento ed è concentrato nei luoghi dove si balla. Rispetto al quando si nota che labuso di alcol e luso di sostanze stupefacenti sono concentrati nel fine settimana ed aumentano con lora della notte. Nellarea metropolitana luso della cocaina risulta abbastanza diffuso e negli ambienti di vita notturna sembra stia in parte sostituendo lecstasy come sostanza a scopo ricreazionale. Luso di sostanze stupefacenti sembra più diffuso nei locali della città di Bologna, mentre labuso di alcolici pare prevalere in quelli della provincia. Le mode e le abitudini sociali di uno specifico territorio, come anche il tipo di offerta presente nella zona di locali e occasioni di divertimento incidono fortemente sulla scelta di dove passare la serata: la concentrazione e la collocazione geografica dei locali oggetto di indagine inducono ad ipotizzare fenomeni di migrazione sino a tarda notte da e verso la città di Bologna nel corso dei fine settimana.
Si profila un quadro nel quale i modelli di intervento tradizionali (SERT e comunità terapeutiche) ed il bagaglio di esperienza accumulato dagli operatori pubblici e privati nellagire quotidiano con tossicodipendenti ed alcolisti non sembrano offrire punti di riferimento adeguati per possibili interventi nel settore. Preso atto della particolarità di questo target, per quanto riguarda le possibili politiche in materia di prevenzione, le azioni possibili riportate dalla letteratura si possono orientare in due direzioni: 1) mirare alla riduzione generalizzata del consumo; la logica è quella di ridurre con programmi di prevenzione il numero delle persone a rischio di farne un uso più intensivo e problematico. 2) concentrarsi sui gruppi e sugli ambienti ad alto rischio in unottica di riduzione del danno; la questione principale, in unottica di sanità pubblica, è data dai rischi di ledere la propria salute a lungo termine con un consumo regolare di stimolanti e alcol e dai rischi provocati da episodi traumatici invalidanti associati al consumo.
In tutti i casi le strategie scelte vanno supportate da una conoscenza continua e costante dellevoluzione del fenomeno, delle caratteristiche dei consumatori, della tipologia delle sostanze immesse sul mercato e dei rischi connessi alluso. Vanno inoltre individuati e studiati i percorsi che portano dalluso allabuso, alla cronicità e alla dipendenza. Va tenuto presente che in questo campo non possono essere utilizzati i metodi classici di analisi epidemiologica mutuati dallo studio delle dipendenze, e vanno sperimentati strumenti e tecniche innovativi.
Ci sembra opportuno far rilevare che nella provincia di Bologna sono stati avviati numerosi interventi sul territorio in materia di prevenzione e riduzione del danno rivolti a target giovanili e vari sono gli enti o le istituzioni che li hanno promossi. Citiamo alcune delle azioni promosse dai vari enti: Comune di Bologna, Ufficio Lotta alle Droghe: innesti formativi per il personale interno dei locali da ballo e dei locali serali; info-desk presso discoteche e locali serali; formazione allinterno delle scuole su sostanze stupefacenti e doping; formazione di barman. Azienda USL Bologna Città: peer-education allinterno delle scuole; unità di prevenzione. Il Quadrifoglio Soc. Coop: formazione allinterno di scuole. Il Pettirosso Coop Soc.: formazione nelle scuole e formazione rivolta a genitori. Nuova Sanità: formazione nelle scuole. Carovana Coop: interventi sul bullismo; formazione nelle scuole; animazione di centri giovanili. La Rupe Centro Accoglienza: animazione di strada; animazione di centri giovanili; formazione scuole; peer-education. Ass. Asat: formazione nelle scuole. Drop-in del Livello 57: chill-out presso rave. CIC del Settore Istruzione del Comune di Bologna: sportelli informativi presso scuole. Sert di S. Giovanni in Persiceto: animazione di centro giovanile; sportello informativo per adulti; formazione scuole.
Bibliografia di riferimento
Abraham, M. 1999 Illicit drug use, urbanization and lifestyle in the Nederlands, Journal of Drug Issues, vol. 29, n. 3.
Amann Gainotti, M. 1999 Corporeità e tossicodipendenza. Una ricerca sulle rappresentazioni e sui vissuti corporei di giovani tossicodipendenti, Milano, Unicopli.
Cavalli, A. e De Lillo, A. 1993 Giovani anni 90. terzo rapporto IARD sulla condizione giovanile in Italia, Bologna, Il Mulino. 1997 Giovani verso il duemila. Quarto rapporto IARD sulla condizione giovanile in Italia Bologna, il Mulino.
Collin, M. 1998 Stati di alterazione. La storia della cultura ecstasy e dellacid house, Milano, Mondatori.
Cottino A 1991 Lingannevole sponda: lalcol tra tradizione e trasgressione NIS Roma
Critcher, C. 2000 Still Raving: social reaction to ecstasy in Leisure Studies, vol. 19, n. 3.
Dal Lago, A. e Molinari, A. 2001 Giovani senza tempo, Verona, Ombre Corte.
Gruppo Epidemiologico Società Italiana di Alcologia 1997 Limpatto del consumo di alcol sulla salute degli italiani: consumi, prevalenze, frazioni e mortalità attribuibili e prevedibili, strategie di intervento, Italia 1985-1994.
Plant, M. e M. 1996 Comportamenti a rischio negli adolescenti, Trento, Erikson.
Osservatorio Europeo delle Droghe e delle Tossicodipendenze (OEDT) Lisbona Focus sulle droghe 2002: Il consumo di stupefacenti ad uso ricreativo; Misurare la prevalenza e lincidenza del consumo di stupefacenti; Prevenzione in materia di droghe nelle scuole dellU.E. Documenti on line reperibili sul sito: www.emcdda.org
Pavarin RM, A. Salsi 1998 Estimate of present addicts in Bologna in 1998 and analysis of the unknownnumber or them Bollettino per le farmacodipendenze e lalcolismo n. 3 anno 1998
Pavarin RM, A. Salsi 1999 Analisys of the characteristics of the subjects contacted by the Street Workers in the municipality of Bologna first six months period 1998 Bollettino per le farmacodipendenze e lalcolismo n. 1 anno 1999
Pavarin RM, L. Prata 2001 Studio longitudinale sulla mortalità dei tossicodipendenti a Bologna e suoi determinanti Gli ospedali della vita n. 3 luglio 2001 - www\\ossdipbo.org
Pavarin RM, Ruo M, Michaeler M 2002 Studio trasversale sulla prevalenza di tossicodipendenti da sostanze pesanti nellarea metropolitana della provincia di Bologna su rapporto 2001 sulle dipendenze in area metropolitana pubbl. a cura A.USL città di Bologna maggio 2002 - www\\ossdipbo.org Renzetti, C. 2002 La scena dei consumi e dei comportamenti a rischio, paper non pubblicato.
Ruo M, R.M.Pavarin 2001 2Tossicodipendenza e marginalità a Bologna: offerta di servizi e caratteristiche dei soggetti pubbl. a cura A.USL città di Bologna settembre 2001 - www\\ossdipbo.org
Skog Oj 1985 The collectivity of drinking culture: a theory of the distribution of alcol consumption J Addict, 1985
Semprini Cesari, S., Saponaro, A. e Cortese, M. 2000 Certe notti. Alcol droghe e guida. Comportamenti a rischio e strategie dintrvento, Azienda Usl Rimini.
Taggi, F. e Di Cristoforo Longo 2001 I dati socio sanitari della sicurezza stradale, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Torti, M. T. 1997 Abitare la notte Genova, Costa & Nolan
Allegato: Il Questionario
1. Giorno di chiusura: L M M G V S D 2. Giorno di maggior affluenza: L M M G V S D
3. TIPOLOGIA LOCALE: 1. o bar 7. o CS 2. o pub 8. o disco - pub 3. o birreria 9. o sala giochi 4. o discoteca 10. o cocktail - bar 5. o circolo 11. o enoteca 6. o osteria 12. o ristorante
4. CAPIENZA: . Posti a sedere: posti in piedi: ..
TARGET:
5. Età in classi in percentuale per sesso:
6. Presenza di studenti: sì o no o 7. Presenza di gay: sì o no o 8. Presenza di stranieri: sì o no o 9. Specificare: 1. o occidentali 2. o magrebini 3. o africani 4. o latino-americani 5. o asiatici
10. TIPO DI FRUIZIONE: 1. o aperitivi 5. o ballare 2. o happy hour 6. o after hour 3. o pre discoteca 7. o si mangia 4. o post - discoteca
11. GENERI MUSICALI PROPOSTI: durante la settimana nel fine settimana sempre
ABUSO DI ALCOLICI: 13. Ha notato abuso di alcolici? Sì o No o Talvolta o 14. Se sì, può specificare: dentro al locale o fuori dal locale o
15. Quali sono i giorni di abuso? 16. Può specificare di quale tipo di alcolici si abusa? 17. Le risulta che si verifichi un abuso di un alcolico specifico in un particolare giorno della settimana?
CONSUMO DI SOSTANZE 18. Ha notato consumo di sostanze? Sì o No o Talvolta o 19. Se sì, può specificare: dentro al locale o fuori dal locale o
20. Quali sono i giorni in cui si usano sostanze? 21. Di quali tipi di sostanze ha notato luso? 22. Ha notato luso di qualche sostanza in particolare in specifici giorni della settimana?
Difficoltà: sì o no o In quali items:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La pagina
- Educazione&Scuola©